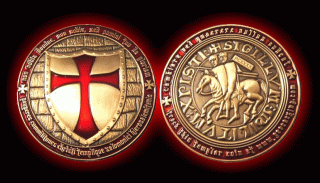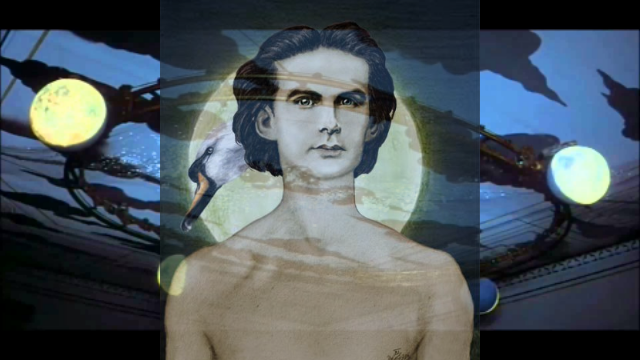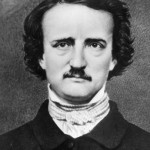|

LUDWIG OF BAVARIA: a personal reminiscence
The adjustment of the estates of three of my French ancestors, who died in Rouen about eight years ago, necessitated my going to Bavaria. As the three deaths, being almost simultaneous, resulted in unprecedented complications, it was manifest, from the very first, that audience must be had with the Bavarian king. So, in leaving France, I bore with me, to Ludwig, a letter of introduction from M. Gambetta, which fully explained my mission and requested the king to facilitate my endeavors as far as possible. Arriving in Munich, I sent my letter to his royal highness, expecting, of course, to be turned over to the tender mercies of some deputy, after his usual custom. To my surprise, Gambetta’s letter resulted in my being requested to wait upon the king at the royal palace the next morning at ten o’clock. Punctual to the second, I was shown into a
beautifully-decorated sitting- room, where the monarch joined me after a brief delay.
To others he may have always been brusque, morose, and taciturn, but no one could have been more affable and gracious than he was that morning. He examined my papers with the most courteous interest, and weighed the whole matter with as much thoughtful consideration as if it had been something of vital concern to him. Waiving several Bavarian customs, for my convenience, and setting me straight in every possible direction, he was about ending the interview, when he suddenly caught sight of something which prolonged my audience with him for two of the most delightful hours which were ever owed to royal clemency. Leaving France, as I did, a day earlier than I had intended, in my haste I accidentally packed with my legal documents the proof-sheets of a paper which I had been writing for Figaro on Edgar Allan Poe. The proofs were left unnoticed with the other papers until the whole package was opened and spread out on the king’s table. Until then his manner had been quiet and gentle, almost to effeminacy; but the moment he saw Poe’s name be became all eagerness and animation. His magnificent eyes lit up, his lips quivered, his cheeks glowed, and his whole face was beaming and radiant.
“Is it a personal account of him?” he asked. “Did you know Poe? Of course you did not, though: you are too young. I cannot tell you how disappointed I am. Just for a moment I thought I was in the presence of someone who had actually known that most wonderful of all writers, and who could, accordingly, tell me something definite and authentic about his inner life. To me he was the greatest man ever born, -greatest in every particular. But, like many rare gems, he was fated to have his brilliancy tarnished and marred by constant clashings and chafings against common stone. How he must have suffered under the coarse, mean indignities which the world heaped on him ! And what harsh, heartless things were said of him when death had dulled the sharpness of his trenchant pen ! You will better understand my enthusiasm when I tell you that I would sacrifice my right to my royal crown to have him on earth for a single hour, if in that hour he would unbosom to me those rare and exquisite thoughts and feelings which so manifestly were the major part of his life.”
His voice softened into a low monotone – almost a wail – as he approached the end of his sentence, and his head kept settling forward until his chin rested upon his breast. He kept this attitude, in dead silence, for several minutes, his face wearing an expression of the most intense sorrow. Suddenly arousing himself, he glanced at me in startled surprise, as if he had for the moment forgotten my presence. Then his eyes beamed pleasantly, and he laughed-clear, merry, ringing laugh-at being caught in a day-dream.
“Will you be good enough to let me read, what you have written?” he asked. “I see that it is in French, the only language I know except my own.”
I handed him the proofs, and watched him as he read them. As the paper was chatty and gossipy, rather than critical, he seemed to enjoy it.
“I see by this that you, also, are fond of Poe,” he said, handing the proofs back to me; “and so I will tell you of a little fancy which I have cherished ever since I first began reading the works of your great fellow-American. At first, because of my respect for his genius and greatness, the lightest thought of what I am going to tell you would make my cheeks burn with shame at my presumption. After a time, I would occasionally write out my fancy, only to burn it, always, as soon as finished. Eventually I confided it to two trusted and valued friends; and now, in some unaccountably strange way, moved, perhaps, by the sympathy born of our common interest in Poe, I am going to take you into my confidence in this particular, stranger though you are. What I have to say is this : I believe, for reasons which I will give you, that there is a distinct parallel between Poe’s nature and mine. Do not be misled by assuming that I mean more than I have said. I but compared our natures: beyond that the parallel does not hold. Poe had both genius and greatness.
I have neither. He had, also, force and strength, so much of both that he could defy the world, sensitive and shrinking as he was. That I never can do. Not that I am a coward, as the word is generally understood, because pain and death can neither shake nor terrify me. Yet any contact with the world hurts me. The same as Poe’s, my nature is abnormally sensitive.
Injuries wound me so deeply that I cannot resent them : they crush me, and I have no doubt that in time they will destroy me. Even the laceration my heart received from indignities which I suffered as a child are still uneffaceable. A sharp or prying glance from the eyes of a stranger, even though he be only same coarse peasant, will annoy me for hours; and a newspaper criticism occasions me endless torture and misery. The impressionable part of me seems to be as sensitive as a photographer’s plate : everything with which I come in contact stamps me indelibly with its proportions. My impulses, it can be no egotism to say, are generous and kindly; yet I never, in my whole life, have done an act of charity that the recipient did not in some way make me regret it. People disappoint me; life disappoints me. I meet some man with a fine face and fine manner, and believe in the sincerity of his smile. Just as I begin to feel certain of his lasting love and fidelity, I detect him in some act of treachery, or overhear him calling me a fool, or worse.”
Arising, he began to walk slowly up and down the room.
“Apparently,” he continued, after a brief silence, “there is no place in the economy of life except for one kind of man. If one would be respected, he must be coarse, harsh, and phlegmatic. Let him be anything else, and friends and foes alike unite in declaring him eccentric. Much as I despise the gross, sensual creatures who wear the form and receive the appellation of man, I sometimes regret that I am not more like them, and, so, more at ease. They plunge into excesses with no more concern than a duck feels in plunging into a lake. With me the thought, or rather the dread, that I may some day so far forget myself as to debase and degrade myself, according to the common custom of man, is in itself sufficient cause for the most excruciating torture. When I look upon men as they average and see the perfect nonchalance with which they commit this, that, or the other abuse from which I would recoil with utter repugnance, I wonder if, after all, they are not really to be envied.
My condition is as much of a puzzle to me as it possibly can be to you. Logically, there is no reason for it. My father and mother were neither abnormally sensitive nor excessively moral. So far as I am able to ascertain, they regarded things in life very much as every one else does. It was the same, I believe, with the parents of Poe. Things he has written prove to me that he felt the same disgust for whatever demoralizes that I have always felt, only he saw how the world would behave towards him if he did not seem in sanction and approve of its rottenness. I do not blame him. His way was wisest. Deceit is best in such a case, if it can only be
assumed.
With his sensitiveness were associated force and defiance,-two traits which I seriously lack. Perhaps, though, he could endure the world more easily than I can, because his childhood was less dreadful than mine. All through my infancy things were done which stung and wounded me. Not that I was treated more harshly than children commonly are, but because my nature was so unlike that of children in general that the things which never disturbed them were offensive to me. I soon learned that companionship meant pain, and that I could never know or feel anything like content unless I held myself aloof from every one. This, for a man, is hard enough to do; for a child it is next to impossible.
I was forced to subject myself to the will of harsh, unfeeling teachers, and to the society of those who, scarcely more than animals themselves, accredited me with no instincts finer than their own. Most of the studies thrust upon me seemed dull, stupid, and worthless: because they so jarred upon me that my understanding faculties were dulled and blunted with pain, I was declared half-witted. For hours I would sit and dream beautiful day-dreams; and that won for me similar epithets. It is a misfortune to be organized as I am; yet I am what I am because a stronger will and power than mine made me so. In that lie my sole solace and comfort for having lived at all. If my reading and observation have not been in the wrong direction, much of the phenomenon which is called insanity is really over-sensitiveness. It is often hinted, and sometimes openly declared, that I am a madman. Perhaps I am; but I doubt it. Insanity may be self-hiding. An insane man may be the only person on earth who is not aware of his insanity.
Of course I, for such reasons, may not be able to comprehend my own mental condition, except in an exaggerated and unnatural way. But I believe myself a rational being. That, though, may be proof of my insanity. Yet I doubt if any insane person could study and analyze himself as I have done and still do. I am simply out of tune with the majority of my race. I do not enter into man’s common pleasures, because they disgust me and would destroy me. Society hurts me, and I keep out of it. Women court me, and for my safety I avoid them. Were I a poet, I should be praised for saying these things in verse; but the gift of utterance is not mine, and so I am sneered at; scorned, and called a madman. Will God, when he summons me, adjudge me the same?”
With tearful eyes, he pressed my hand, smiled, and left the room. The learned doctors have already declared Ludwig of Bavaria insane, and kindlier judgment from those who loved him would very likely be counted wasted sympathy by the world.
Lew Vanderpoole |
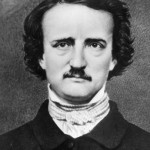
LUDWIG DI BAVIERA: un
ricordo personale
La sistemazione delle
proprietà di tre dei miei antenati francesi, che erano morti a Rouen circa otto anni fa, ha reso necessaria la mia visita in Baviera. Visto che le tre morti, essendo state quasi simultanee, avevano determinato delle
complicazioni senza precedenti, era evidente, fin dall’inizio, che si doveva avere un’udienza con il re bavarese. Così, nel lasciare la Francia, portai con me, per Ludwig, una lettera di presentazione da parte di M. Gambetta, che ampiamente spiegava la mia missione e chiedeva al re di facilitare i miei sforzi, per quanto possibile. Arrivato a Monaco di Baviera, inviai la mia lettera a Sua Altezza Reale, in attesa, naturalmente, di essere consegnato alla discrezione
di qualche funzionario, secondo il suo usuale comportamento. Con mia grande sorpresa, la lettera di Gambetta sortì l’effetto che io fossi invitato ad attendere il re a Palazzo Reale la mattina seguente alle dieci. Puntuale al secondo, fui ammesso in un salottino finemente
arredato, dove il monarca mi raggiunse, dopo un breve ritardo.
Con altri egli può essere sempre stato brusco, cupo, e taciturno, ma quella mattina nessuno avrebbe potuto essere più affabile e gentile di lui. Esaminò i miei documenti con l’interesse più cortese, e pesava l’intera questione con la stessa considerazione pensierosa come se fosse stato qualcosa di importanza vitale per lui. Rinunciando a diverse consuetudini bavaresi, a mio vantaggio, e avendo messo le cose in chiaro in ogni possibile direzione, era sul punto di terminare il colloquio, quando improvvisamente vide qualcosa che prolungò la mia udienza con lui per due delle più deliziose ore che siano mai state concesse dalla clemenza reale. Lasciando la Francia, come avevo fatto, un giorno prima di quanto avessi previsto, nella fretta avevo accidentalmente impacchettato con i miei documenti legali una bozza di un pezzo che avevo scritto per Le Figaro su Edgar Allan Poe. La bozza era passata inosservata tra le altre carte fino a quando l’intero pacchetto era stato aperto e sparso sul tavolo del re. Fino ad allora il suo modo di comportarsi era stato tranquillo e gentile, quasi effeminato; ma nel momento in cui vide il nome di Poe divenne pieno di entusiasmo e animazione. I suoi magnifici occhi si illuminarono, le labbra tremavano, le guance brillavano, e tutto il suo volto era raggiante e luminoso.
“Si tratta di un ricordo personale di lui?” Egli chiese. «Conosceste personalmente Poe? Naturalmente non è possibile, comunque: siete troppo giovane. Io non so dirvi quanto sono dispiaciuto da ciò. Solo per un attimo ho pensato che ero in presenza di una persona che nella realtà aveva conosciuto il più meraviglioso degli scrittori, e che avrebbe potuto, di conseguenza, dirmi qualcosa di preciso e autentico della sua vita interiore. Per me egli è stato il più grande uomo mai nato, il più grande in ogni particolare. Ma, come molte gemme rare, è stato destinato a vedere il suo splendore appannato e segnato da colpi costanti e scalfitture contro la pietra comune. Come deve aver sofferto sotto le grossolane, crudeli umiliazioni che il mondo ha riversato su di lui! e che cose dure, senza cuore si dicevano di lui quando la morte ebbe offuscato la nitidezza della sua penna tagliente! Voi potete capire meglio il mio entusiasmo quando vi dico che sacrificherei il mio diritto alla corona regale per averlo sulla terra una sola ora, se in quell’ora confidasse a me quei pensieri e sentimenti rari e raffinati, che così palesemente costituivano la maggior parte della sua vita”.
La sua voce si addolcì in una nota bassa monotona, quasi un gemito, mentre si avvicinava la fine del suo discorso, e la sua testa continuava a abbassarsi in avanti fino a quando il suo mento poggiò sul petto. Mantenne questo atteggiamento, in un silenzio di tomba, per alcuni minuti, mentre il suo volto assumeva un’espressione del più intenso dolore. improvvisamente risollevandosi, egli mi guardò estremamente sorpreso, come se avesse dimenticato, in quella circostanza, la mia presenza. Poi i suoi occhi splendettero piacevolmente, e lui rise con una risata chiara, allegra, squillante per essere stato catturato in un sogno ad occhi aperti.
“Sareste così gentile da farmi leggere, quello che avete scritto?” egli chiese. “Vedo che è in francese, l’unica lingua che conosco, oltre alla mia.” Gli porsi la bozza, e lo osservai mentre la leggeva. Appena il pezzo diventava ciarliero e pettegolo, piuttosto che critico, sembrava divertirsi.
“Vedo da questo che anche voi siete un appassionato di Poe”, disse, restituendomi la bozza “E così vi racconterò una piccola fantasia che ho vagheggiato fin da quando cominciai a leggere per la prima volta le opere del vostro grande compagno americano. In un primo momento, a causa del mio rispetto per il suo genio e la sua grandezza, il più lieve
pensiero di quello che sto per dirvi avrebbe reso le mie guance brucianti di vergogna per la mia presunzione. Dopo un po’, ho voluto occasionalmente scrivere la mia fantasticheria, solo per bruciare il foglio, sempre, non appena terminato. Alla fine l’ho confidata a due amici fidati e valutati; ed ora, in qualche inspiegabilmente strano modo, commosso, forse, dalla sintonia nata dal nostro comune interesse in Poe, sto per rivelarvi una mia confidenza riguardo questo particolare, sebbene voi siate un estraneo. Quello che ho da dire è questo: credo, per ragioni che vi illustrerò, che vi sia un netto parallelo tra la natura di Poe e la mia. Non lasciatevi ingannare dal presupposto che io voglia dire più di ciò che ho detto, ma confrontate la nostra natura: al di là che il parallelo non regge. Poe aveva sia il genio sia la grandezza. Io non ho nessuno dei due. Aveva, anche, la forza e la resistenza, entrambe in modo così cospicuo che avrebbe potuto sfidare il mondo, sensibile e chiuso come doveva essere. Cosa che io non potrò mai fare. Non che io sia un codardo, come la parola è generalmente intesa, perché il dolore e la morte non possono scuotermi né mi terrorizzano. Eppure, ogni contatto con il mondo mi fa male. Come lo stesso Poe, la mia natura è sensibile in modo abnorme.
Le offese mi feriscono così profondamente che non posso restituirle: mi schiacciano, e non ho alcun dubbio che nel tempo finiranno per distruggermi. Anche le lacerazioni che mio cuore ha ricevuto da umiliazioni che ho sofferto da un bambino sono ancora incancellabili. Uno sguardo tagliente o indiscreto dagli occhi di un estraneo, anche se egli sia solo lo stesso contadino rozzo, può disturbarmi per ore; e le osservazioni critiche di un giornale causano in me una miseria e tortura senza fine. La parte impressionabile di me sembra essere sensibile come una lastra fotografica: tutto ciò con cui vengo in contatto si imprime in me in modo indelebile con le sue proporzioni. I miei impulsi, non può essere considerata immodestia dirlo, sono generosi e gentili; eppure non ho mai, in tutta la mia vita, compiuto un atto di carità del quale il destinatario non mi abbia fatto, in qualche modo pentire. Le persone mi deludono; la vita mi delude. Incontro un uomo con un viso raffinato e maniera elegante, e credo nella sincerità del suo sorriso. Appena inizio a sentirmi certo del suo amore duraturo e della sua fedeltà, lo colgo in qualche atto di tradimento, o lo sento mentre mi chiama stupido, o peggio “.
Alzatosi, cominciò a camminare lentamente su e giù per la stanza.
“A quanto pare” continuò, dopo un breve silenzio,” non c’è posto nell’economia della vita se non per un solo tipo di uomo. Se un uomo vuole essere rispettato, deve essere rozzo, duro e flemmatico. Lascialo essere qualsiasi altra cosa, e sia gli amici sia i nemici allo stesso modo si uniscono nel dichiararlo un eccentrico. Per quanto io disprezzi le laide creature sensuali che vestono la forma e ricevono l’appellativo di uomo, a volte mi dispiace di non essere maggiormente come loro, e, quindi, più a mio agio . Essi si gettano negli eccessi senza una preoccupazione maggiore di quanto ne senta una papera nell’immergersi in un lago. Per me il pensiero, o meglio la paura, che io possa un giorno per quanto lontano dimenticare me stesso fino a svilirmi e a degradarmi, secondo l’abitudine comune dell’uomo, è di per sé motivo sufficiente per le torture più atroci. Quando guardo agli uomini come media e vedo la disinvoltura perfetta con la quale commettono questo, quello o un altro abuso da cui mi ritrarrei con ripugnanza assoluta, mi chiedo se, dopo tutto, in realtà non siano da invidiare.
La mia condizione è come un rompicapo per me come, eventualmente, può esserlo per voi. Da un punto di vista logico, non vi è alcuna ragione per questo [mio modo di essere]. Mio padre e mia madre non erano né anormalmente sensibili né eccessivamente moralisti. Per quanto io sono in grado di accertare, essi consideravano le cose nella vita moltissimo come ogni altro fa. E’ stato lo stesso, credo, con i genitori di Poe. Le cose che ha scritto mi dimostrano che egli provava lo stesso disgusto per qualsiasi corruzione come quello che ho sempre sentito, solo che lui si rese conto di come il mondo si sarebbe comportato verso di lui, se non avesse dato l’impressione di autorizzare e approvare la sua putredine. Io non lo biasimo. Il suo modo di reagire era più saggio. La finzione è la scelta migliore in un caso del genere, se è l’unico atteggiamento possibile da assumere. Con la sua sensibilità sono state associate forza e sfida, – due caratteristiche di cui sento seriamente la mancanza. Forse, però, avrebbe potuto sopportare il mondo più facilmente di me, perché la sua infanzia fu meno terribile della mia. Durante tutta la mia infanzia sono state fatte cose, che mi hanno angosciato e ferito. Non che io sia stato trattato più duramente rispetto a come comunemente sono trattati i bambini, ma perché la mia natura era così diversa da quella dei bambini, in generale, che le cose che non li disturbavano erano offensive per me. Ho imparato presto che compagnia voleva dire dolore, e che non avrei potuto mai sapere o sentire alcun piacere a meno che io mi tenessi in disparte da tutti. Questo, per un uomo, è abbastanza difficile da fare; per un bambino è quasi impossibile. Sono stato costretto ad assoggettarmi alla volontà di duri, insensibili insegnanti, e alla compagnia di coloro che, poco più che animali essi stessi, mi ritenevano con istinti non più raffinati dei loro. La maggior parte degli studi imposti a me sembrava noioso, stupido e inutile: poiché mi mettevano in una tale agitazione che le mie facoltà di apprendimento erano offuscate e limitate dal dolore, io fui dichiarato praticamente stupido. Per ore avrei potuto sedere e immaginare bei sogni ad occhi aperti; e per questo mi sono guadagnato epiteti simili. E’ una disgrazia essere impostato come lo sono io; eppure io sono quello che sono perché una volontà e una potenza più forte di me stesso mi ha reso così. In quella illusione sta il mio unico sollievo e conforto per non aver vissuto affatto. Se la mia lettura e osservazione non sono andate nella direzione sbagliata, la maggior parte del fenomeno chiamato pazzia consiste in realtà un eccesso di sensibilità. Si è spesso accennato, e talvolta apertamente dichiarato, che io sono un pazzo. Forse lo sono; ma ne dubito. La pazzia può nascondersi a se stessa. Un uomo folle può essere l’unica persona sulla terra che non è a conoscenza della propria follia. Certo che, per tali motivi, io potrei non essere in grado di comprendere la mia condizione mentale, se non in modo esagerato e innaturale. Ma io credo di essere un individuo razionale. Questa, però, potrebbe essere la prova della mia pazzia. Eppure dubito che qualsiasi persona folle potrebbe studiare e analizzare se stesso come ho fatto e ancora faccio io. Sono semplicemente fuori sintonia con la maggior parte della mia razza. Non mi dedico ai piaceri comuni dell’uomo, perché mi disgustano e mi distruggerebbero. La società mi fa male, e io mi tengo fuori da essa. Le donne mi corteggiano, e per la mia sicurezza le evito. Se fossi un poeta, sarei lodato per il fatto di esprimere queste cose in versi; ma il dono della parola non mi appartiene, e quindi sono deriso; disprezzato, e chiamato pazzo. Dio, quando mi chiamerà, mi giudicherà nello stesso modo?”
Con gli occhi pieni di lacrime, strinse la mia mano, sorrise e lasciò la stanza. I dottori hanno già dichiarato Ludwig di Baviera pazzo, e un giudizio più gentile da parte di coloro che lo hanno amato avrebbe molto probabilmente messo in evidenza la sensibilità frustrata dal mondo.
Lew Vanderpoole “ |